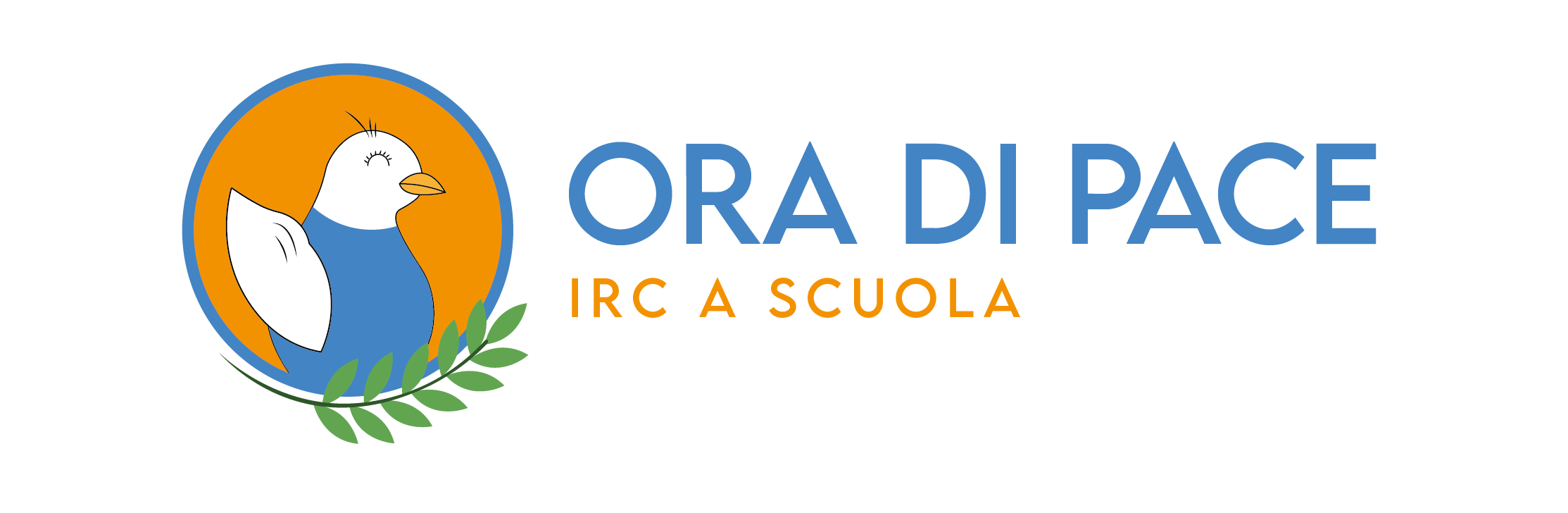Il peso della valutazione

Di Luciano Pace
Come ormai è chiaro, la decisione di alcuni noti maturandi di non presentarsi alla prova orale dell’esame di Stato, di cui ancora si discute sui media e sui social in questi giorni, ha innescato diverse reazioni e sensibilità, tra cui anche quella del Ministro Valditara, il quale ha minacciato la bocciatura per chi, nel prossimo anno scolastico, dovesse boicottare nuovamente l’esame. Ci si potrebbe domandare se e quanto possa essere educativa una misura di ordine repressivo.
Infatti, posto che qualsiasi sistema organizzativo tende a tutelare sé stesso, si potrebbe comunque cercare di comprendere per quali ragioni questi studenti hanno protestato, visto che chi si occupa di scuola si interessa di una forma dell’educazione. A quanto si capisce, il loro intento era di protesta verso un sistema scuola che è da loro (e da molti altri studenti loro coetanei) percepito come alienante e opprimente. In particolare, l’impressione è che la maggior parte degli insegnanti sia preoccupata dei voti, delle verifiche, dei giudizi e non delle persone che imparano.
Una simile protesta può essere considerata in molti modi. Si può polemizzare verso l’atteggiamento degli studenti a motivo del fastidio procurato dalla loro scelta. Si può esaltare il loro gesto, quando lo si considerasse coraggioso; anche se, converrebbe comunque ricordare, come diversi hanno segnalato, che la loro protesta non è costata nulla, visto che erano già promossi dopo aver sostenuto gli scritti. Si potrebbe anche decidere di non dare troppa importanza a quanto accaduto: infondo, si tratta di pochi studenti che hanno preso una decisione assumendosene la responsabilità e motivando la loro condotta, come si addice a chi è adulto.
Tra tutte le possibili angolature di senso, c’è anche quella di chi, da insegnante, riflette su ciò che accade nella scuola, in quanto la frequenta quotidianamente. Molti insegnanti che si sono espressi sulla questione, infatti, pur non condividendo la modalità della protesta di questi maturandi, si sono concentrati sulle loro motivazioni, facendo notare come non abbiano, in effetti, tutti i torti. Per chi volesse posizionarsi da questo angolo di visuale, cogliendo la loro provocazione, potrebbe riflettere con un po’ più di calma sul significato della valutazione scolastica, la vera questione posta da loro sotto accusa.
Un aiuto in questa direzione viene dalla lettura del recente libro di Cristiano Corsini, intitolato “La fabbrica dei voti. Sull’utilità e il danno della valutazione a scuola”, edito dalla Laterza. Il testo invita il lettore ad interrogarsi sul significato educativo delle prassi valutative nei processi di apprendimento. Per esempio, pone sotto critica la consolidata abitudine del fare la media aritmetica delle valutazioni. Infatti, se su un determinato argomento lo studente ha ottenuto “4” in una verifica, ma, successivamente, sempre su quell’argomento ha preso “8”, al termine del processo il 4 precedente non esiste più. È svanito.
Rimarcare il fatto che “Però prima aveva preso 4!”, sarebbe come apostrofare Jannik Sinner dopo aver vinto Wimbledon dicendogli: “Eh, però, ai Roland Garros hai perso”. L’errore, in un processo di apprendimento, è semplicemente qualcosa da superare, non qualcosa tramite cui essere continuamente giudicati. In realtà, per chi vive nella scuola da insegnante, sa benissimo che la media aritmetica delle valutazioni è solo un espediente psicologico che permette di sentirsi meno inadeguati agli scrutini. Per qualche ragione, dona tranquillità e un’impressione di imparziale equità al momento cruciale della valutazione scolastica.
Nella sua sostanza, l’impostazione di Corsini richiama un principio già posto in luce nel ‘900 da Karl Raimund Popper, il più importante filosofo della scienza del XX secolo. Egli ha continuato a riflettere per tutto l’arco della sua produzione filosofica sul significato dell’errore connesso alla logica della scoperta scientifica. La sua conclusione, a dire il vero, è molto semplice ed intuitiva: fare scienza significa comprendere ed emendare i propri errori grazie all’aiuto di chi, con competenza, critica le nostre teorie ed imprese. Questo esercizio critico non ha come suo scopo screditare chi sbaglia, ma corroborare, ovvero rendere più raffinato, ciò che sta compiendo.
Ora, il significato formativo della valutazione scolastica proposto da Corsini è esattamente lo stesso: i voti negativi sono segnali di ciò che, in un processo di apprendimento, va perfezionato perché le lacune, pian piano, siano riempite e spariscano. La tendenza contraria, diffusa ancora largamente a scuola e denunciata dalla protesta dei “maturandi ribelli”, è quella di chi fa credere agli studenti che i loro voti negativi saranno sempre lì a disposizione come sassi con cui lapidarli, nella faretra che gli insegnanti stessi hanno posto sulle loro spalle.
Non c’è quindi da meravigliarsi troppo se questi studenti hanno cercato in questi giorni di togliersi di dosso quel peso in maniera plateale. Si può star certi che moltissimi altri hanno terminato la loro maturità dopo l’esame orale con l’impressione di essersi tolti di dosso la stessa faretra, sia oggi che in passato, anche se non lo hanno manifestato pubblicamente.