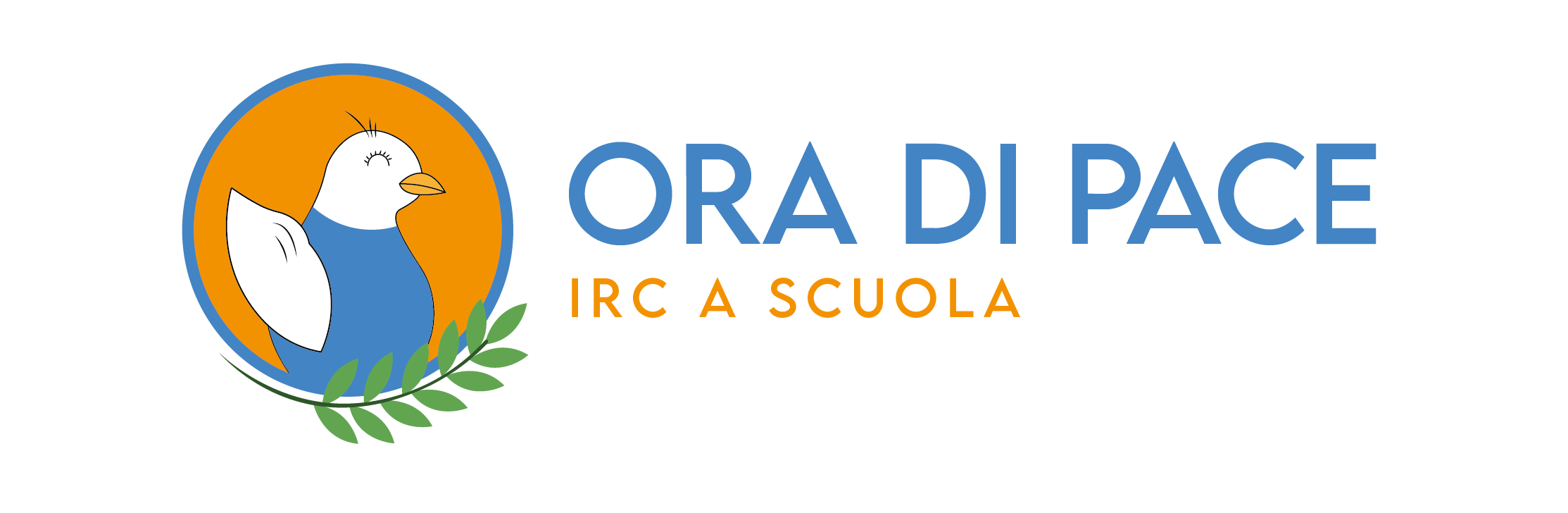La morte di un capolavoro

Giselle Passannante Grimaldi, una studentessa della quinta Liceo scientifico, ha voluto onorare il blog con questo suo scritto in cui racconta, in maniera riflessiva e con punte di sana ironia, che cosa significa per lei la Letteratura e che cosa abbia voluto dire imparare a comprenderne il senso profondo nella sua crescita. Questa signorina ha 18 anni (che ci crediate o no), ma dimostra già una statura intellettuale ed umana che si spera possa ulteriormente crescere e svilupparsi.
“La letteratura non è solo un gioco intellettuale, ma è l’unico modo per capire il mondo” – Roberto Cotroneo
Diversi anni fa, una persona di mia conoscenza si chiedeva per quale stramba ragione le persone si ostinassero a leggere quei mattoni polverosi. Non è passato poi molto tempo da quando ragionava sul senso di approcciarsi ad una sostanza che percepiva come statica, sterile. Morta.
Non sa bene cosa l’abbia portata, nel corso del tempo, a cambiare la propria convinzione: era una bambina testarda quella che pensava queste cose. Le piaceva la matematica, costruire impianti idrici con le cannucce ed i bicchieri di plastica ed indagare tutto quello che avesse un senso, una causa ed un effetto: amava vedere le cose prendere vita, formarsi, funzionare e ripararle quando lo scotch si inzuppava troppo e perdeva aderenza, spruzzando acqua per tutto il patio.
Tutto ciò verso cui fosse costretta ad avere un atteggiamento passivo non suscitava in lei il benché minimo interesse.
Gli anni passavano e, tutto ad un tratto, da degna figlia del positivismo, ella scoprì che doveva cominciare a trovare un po’ di senso anche nei derivati rilegati della clorofilla, per compiere quell’attività bizzarra che si chiama studiare. Ma come si fa!
“Ma come si fa!” si chiede oggi la stessa persona. Una persona che il senso, alla fine, in mezzo a tutti quei fogli, lo avrebbe anche trovato, ma si chiede come si possa fare a tornare indietro, a quando non lo vedeva. Perché vedere fa male, soffrire fa paura e l’umanità è vigliacca. Vigliacca al punto da far morire un capolavoro.
Certa che siate arrivati fino a questo punto con qualche dubbio e, se ho fatto bene il mio lavoro, con un po’ di angoscia, vi propongo di diradare la nebbia, sperando che il sole sia più gradito ai vostri stomaci.
Innanzi tutto, la bambina che amava la matematica e lavorare con le cannucce non è un personaggio preso da un libro, con la faccia paffuta e l’abbigliamento da maschiaccio: sono io. Ero io. In alcuni momenti mi manca e in altri, i più felici, scopro che mi abita ancora, ma vorrebbe scorrazzare libera un po’ più spesso. In secondo luogo, complimenti per aver scelto di curiosare nei meandri di un articolo con un titolo così tetro.
Una delle cose che mi domandavo nella fase di transizione da scienziato pazzo a donna che ama la letteratura (ma conserva i capelli del modello originale) era: a cosa serve la letteratura? Perché si scrive? Vi chiedo di domandarvelo.
Ora che avete dato una risposta e avete pensato alla banalità della domanda o al suo monolitico volume, ve ne regalo un’altra: può morire?
La letteratura non respira, non si alimenta, non si riproduce: non fa nulla che in biologia abbia a che fare con la vita. Allo stesso modo potremmo trattare, in generale, ogni traccia scritta che l’uomo lascia sulla Terra.
E le arti visive allora? I quadri? Le stampe? Restano legate, sebbene solo minimamente in alcuni casi, ad una visione antropologica, che fa sì che alla domanda “A cosa serve?” possiamo dare una risposta. Tutti ci ricordiamo di come abbiamo imparato a scrivere in prima elementare, vero? Come avremmo fatto senza l’alfabetiere quando arrivava la fatidica ora di scrivere “xilofono” in corsivo e il problema era proprio la “x”.
Se, dunque, la letteratura è biologicamente morta, noi che siamo vivi che ce ne facciamo? L’iconografia, il disegno, hanno uno scopo: sono stati per secoli, fino a non molto tempo fa, la maggiore fonte di cultura per le masse analfabete. Un segno sulla carta, però, che isolato non ci dice niente e che, accoppiato con altri, alla vista lascia ancora più perplessi, che utilità ha?
Nessuna! È ciò che ci ripetono gli strenui sostenitori dello scientismo che, alla sola idea che esista un’altra versione dei fatti nero su bianco, tremano. Quanto sarebbe bello crederci! Noi esseri umani amiamo immaginarci complicati: alimenta il nostro ego. Se la scrittura è nata 5000 anni fa con i Sumeri ed ha segnato l’inizio della Storia, è un po’ idealistico credere che si scrivesse per diletto – i Sumeri non avevano tempo da perdere! O forse, non avevano i mezzi per accorgersi di quanto sarebbe stato bello.
Tutto ciò che abbia a che fare con la natura ha uno scopo. Madre Natura è come la vecchia zia dal braccino corto che abbiamo tutti: se può fare una cosa spendendo il meno possibile, si dà da fare come se avesse vinto un terno al lotto! Altrimenti mi spiegate cosa ci facciamo noi umani con il coccige negli anni 2000? Niente, ma reputiamoci fortunati, per quanto a molti di noi farebbe comodo, che ci abbia privato della coda.
Dunque, se la scrittura è utile, perché sin dall’Antichità era usata per trasmettere messaggi e tenere traccia delle cose, come si è arrivati a studiare le vite di personaggi che hanno fatto gli scrittori di professione o che sono passati alla storia per quello che ritenevano un passatempo?
Forse perché la letteratura serve, ma non nel senso utilitaristico con cui siamo soliti concepire la realtà. La necessità che muove una penna è certamente diversa da quella che muove un aratro a braccia: d’altronde, se la fatica si pagasse a torte, credo che il contadino terrebbe molto alla precisazione. Coltivare ed arare il suolo sono attività necessarie per ottenere cibo, il quale evita la sofferenza del digiuno, mentre l’attività letteraria è la conseguenza, non la causa, della sofferenza.
Ne “La nascita della tragedia” Nietzsche si interroga su cosa ci possa essere dietro la perfezione, la serenità e la magnificenza della Grecia classica e si risponde che ci sono il caos, la malinconia e il dolore: “Quanto dovette soffrire questo popolo per diventare così bello?”.
La scrittura è sempre stata un atto di catarsi: nel film “Dead Poets Society” (L’attimo fuggente), il professor John Keating, interpretato da Robin Williams, afferma, per far comprendere il senso della letteratura ai suoi studenti, che “non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino: noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento, ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore: sono queste le cose che ci tengono in vita.”
Potrebbe sembrare assurdo, ma se la letteratura non è di per sé vita, è il prodotto di essa che più le somiglia. Si scrive per tante ragioni, anche per noia, ma per essere un capolavoro uno scritto deve avere solo una cosa e non si tratta di un premio letterario o della fama: deve avere un’anima. E l’anima chi credete che gliela dia?
La parola scritta è come un prestanome: urla al mondo ciò che le dai in pasto senza che sia tu a dover perdere la voce. Le si può dare tono, intonazione consistenza, per veicolare ira, amore, gioia, dolore, indifferenza, paura, odio e qualunque sentimento si trovi a metà strada tra questi. Fare letteratura è come un sacrificio perché le si può dare una sola anima: la propria. È come sventrare sé stessi su un tavolo per osservare cosa si annidi nelle nostre viscere; dà corpo alla malattia: è una diagnosi. Se una persona sa scrivere del proprio dolore si sta immettendo nella strada della catarsi.
E qui arriviamo alla tanto agognata risposta a “Perché si scrive?”: perché si soffre. Oppure, nel migliore dei casi, perché si è sofferto e quel dolore ha prodotto un mutamento.
Tuttavia, se la letteratura non si riproduce come i batteri, le domande sì e, forse, alla stessa velocità: perché lasciare in eredità al mondo il prodotto della propria sofferenza? Perché pubblicare opere dense di dramma? Perché non murarle dietro una mattonella insieme alla sofferenza o dare fuoco ad entrambi nel camino?
Mary Olivier, poetessa statunitense, scrisse; “Qualcuno che ho amato, una volta mi diede una scatola piena di tenebre. Ma ci sono voluti anni per capire che anche questo è stato un dono”.
Lo scrittore vede il lettore, lo sente, se lo immagina e gli fa dono dell’unica cosa che sarà in suo possesso per sempre: la sua cicatrice più profonda. La letteratura è frutto della catarsi di un’anima umana, che non ha disdegnato il dolore, ma ha deciso di dargli forma, che non ha opposto resistenza, ma si è lasciata smembrare per rinascere a nuova forma. In giapponese “Kintsugi”, letteralmente “riparare con l’oro”, indica una tecnica usata per riparare gli oggetti che non prevede di nascondere la frattura, ma di renderla il tratto distintivo dell’oggetto, ciò che lo fa unico e meraviglioso. È la tecnica che insegna a prendere il dolore ed a farne l’opera più maestosa della propria vita.
Un’opera letteraria, se si potesse disegnare, sarebbe questo: la crepa più bella del mondo, una frattura che sì, trabocca sangue, ma dal quale nascono rose rosse mozzafiato. La letteratura non sarà viva, ma è la forma di una vita, ciò che una vita lascia sulla Terra, che dice al mondo che qualcuno è nato, è vissuto ed ha sofferto, proprio come chi lo legge e tra quelle righe trova solidarietà e soprattutto parole: parole per dare forma a quello strazio.
Abbiamo, però, lasciato in sospeso la questione della sua morte. Ebbene, la letteratura si può uccidere: non è viva, ma può morire.
Quando si pensa alla poesia e alla letteratura in generale, soprattutto a scuola, si pensa alla punteggiatura, alle figure retoriche, allo stile, al suono… ma il significato? E non parlo dell’analisi testuale. È fondamentale considerare tutti gli elementi appena citati per la fruizione di uno scritto, ma essi non costituiscono affatto il suo messaggio, il testo in sé. Se siamo coscienti di questo, che lo scritto è il contenitore dell’anima di una persona che ha regalato ai posteri fino all’ultima lacrima, metà amara e metà dolce, prima di volare via da questo mondo, perché non la reggiamo? Perché non la comprendiamo? Ci sentiamo sopraffatti o indifferenti, una parte di noi fa scudo contro il dolore degli altri. E non parlo solo di chi assomiglia alla piccola me che ho descritto all’inizio, ma di chi ha studiato, magari si è persino laureato, ha scandagliato ogni angolo di quell’ammasso di vite e non ha trovato niente che animasse la sua.
Abbiamo forse paura di farci fare a pezzi? Inutile negarlo. Forse, non solo si scrive, ma si comincia anche a leggere solo quando si soffre. Spero che gli appassionati di Topolino mi perdoneranno: il vostro mito non è compreso in questa menzione.
Quando diciamo che abbiamo paura di soffrire, siamo sicuri di sapere cosa temiamo? Soffrire deriva dal latino “sufferre”, composto da “sub” (sotto) e “ferre” (portare), ossia “portare da sotto”, o meglio “portare su di sé, sopportare”. Soffrire significa sobbarcarsi di qualcosa, farsene carico fino al momento in cui lo si può scaricare dalle proprie spalle.
Per scrivere e, in particolare, per realizzare quel capolavoro che è la letteratura, si deve soffrire nel senso che si deve essere in grado di prendere su di sé il dolore che attanaglia, stringe come una morsa, soffoca e proprio soffrendolo si può arrivare a compiere quel processo di catarsi che conferisce all’opera la sua magnificenza.
La letteratura muore quando l’uomo smette di soffrire, di attuare questo processo di catarsi, che lo porta ad una conoscenza di sé insuperabile. In questo senso, la vita come atarassia che Epicuro teorizzò non è praticabile, perché perde la sua forma più umana e comunitaria: l’empatia. Empatia deriva da “empátheia”, a sua volta composta da “en” (dentro) e “pathos” (sofferenza, sentimento), ed è l’arte di saper portare dentro di sé, o su di sé, il dolore di un altro come se fosse il proprio: è l’arte di saper soffrire. È un dono atroce, ma è ciò che ci rende umani, è quello che sta alla base della nostra civiltà. In questo senso la letteratura è un dono, perché è il prodotto dell’elaborazione di quel dolore che un’altra persona, in virtù della propria empatia, può soffrire, metabolizzare e catarticamente giungere a una profonda conoscenza di sé stesso. Mai furono più vere le parole di Mary Olivier.
I tempi moderni che viviamo ci stanno, però, pian piano rendendo sterili, indifferenti, addirittura infastiditi da ogni profondità. L’umanità non è mai stata più epicurea: viviamo nel motto “se devo provare dolore, pur di eviralo, preferisco non provare più nulla”. Carlo Crossato scrisse in “Il non detto”: “Se possibile, vorrei una pelle più spessa. Con questa si sente praticamente tutto”. Vi prego di non volerla: la pelle si inspessisce e, oltre ai calli, arriva in dono anche una buona dose di insensibilità. In virtù di questa apatia, l’umanità diventa vile e finisce per uccidere il più grande capolavoro che abbia mai realizzato: quel fiume di vite, gioie, dolori, crescite che è stato travasato in migliaia di volumi, ognuno con il proprio genitore e il proprio nome. Come se fossero dei figli. Come se fossimo noi. Essere indifferenti al dolore di un altro è sintomo di morte: dimenticando come si soffre, come si sente a pelle qualcosa, non troviamo più il senso nella lettura e nella scrittura, perciò finiamo per non dare più valore al lavoro di un uomo che si è smembrato per leggersi e si è raccontato perché noi potessimo leggerci attraverso le sue opere.
L’indifferenza dell’uomo avrà come culmine la morte di un capolavoro e l’omicidio di un uomo già morto. Dunque, per scongiurare il massacro, accogliamo il dono di Mary Olivier, pratichiamo il Kintsugi, l’empatia, e facciamo del dolore quanto di più maestoso e splendente siamo capaci.