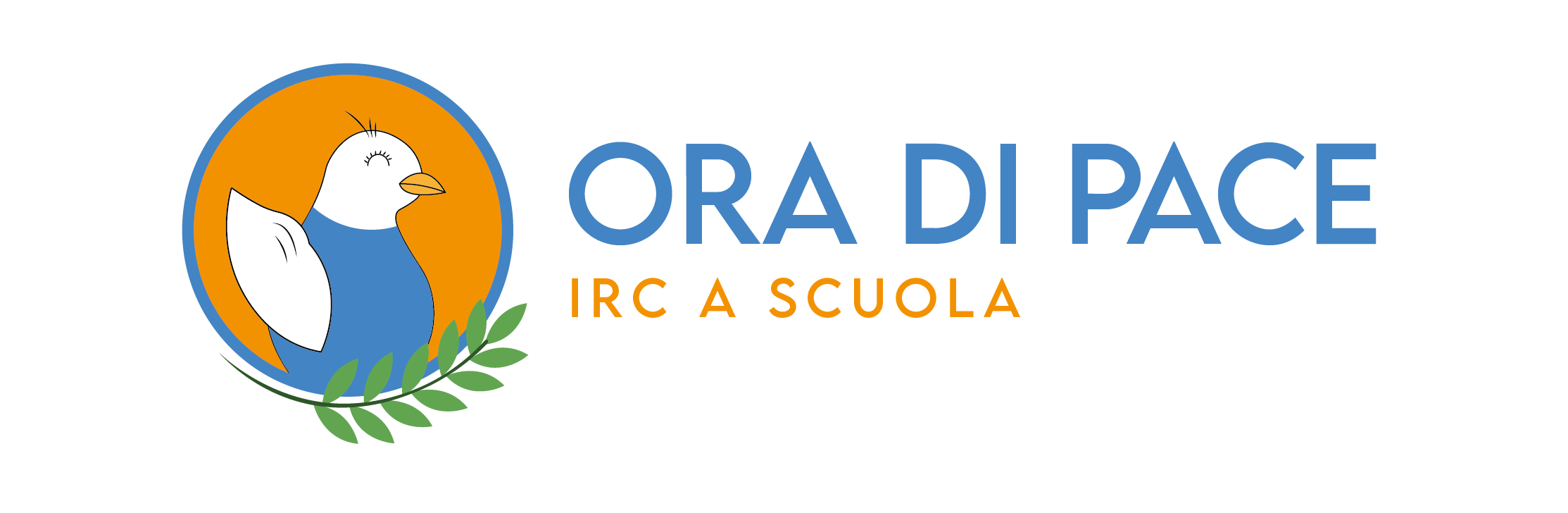Quale specchio? Fra Narciso e Harry Potter

Di Luciano Pace
Fra tutti i miti connessi alla comprensione di sé, quello di Narciso è certamente uno fra i più evocati nel nostro tempo. Non c’è psicanalista che non vi faccia riferimento nelle sue conferenze. Il “narcisismo” è considerato oggi una delle forme di patologia psichica più gravi e fastidiose. Narcisista è chi si preoccupa solo di sé stesso, chi opera allo scopo di riceverne continua ammirazione, chi è incapace di empatia. È l’egoista, che proietta sugli altri l’immagine di sé stesso, come fa il genitore ossessivo verso i figli a motivo delle loro carriere. Ma è anche l’amante infedele che rifiuta la possibilità della vera relazione d’amore, tanto è preoccupato di tutelare sé stesso in ogni effimera conquista sessuale. Il narcisista scappa dall’amore consumando sesso.
Sembrerebbe, quindi, che il problema di Narciso sia quello di rivedere solo sé stesso nelle proiezioni di sé che disloca sugli altri. Questa diffusa interpretazione del mito tende a far pensare che essere come Narciso sia orribile, tanto che il narcisista non merita alcuna compassione. Narciso, nonostante il bel fiore che porta il suo nome, rimane nell’immaginario qui presentato l’orrendo superbo, che si compiace della sua immagine riflessa nell’acqua.
Il problema è che questa interpretazione del mito non corrisponde a ciò che si può evincere dal racconto. Per comprenderne più da vicino la parzialità conviene anzitutto ricordare che Narciso è condannato a innamorarsi della sua immagine riflessa nello stagno. La sua è una condizione tragica: sconta una pena. Secondo quanto emerge dalla versione del mito raccontata da Ovidio, la sua punitrice è la dea Nemesi, figlia di Zeus. Costei aveva udito i continui lamenti della ninfa Ero, che era stata rifiutata da Narciso. Anche Ero, a sua volta, era stata condannata da Giunone, Moglie di Zeus a non potersi esprimere con parole proprie, ma solo ripetendo le ultime dette dal suo interlocutore. Di conseguenza, la ninfa non poteva prender parola per prima, di sua spontanea volontà. La condanna di Ero dipendeva dal fatto che aveva distratto Giunone con lunghi racconti mentre altre ninfe se la intendevano con Zeus, suo marito.
Perciò, quando il cacciatore Narciso sente passeggiare Ero nel bosco, la chiama, ma lei non gli può rispondere. Allora la ninfa gli corre incontro e lo abbraccia. Egli, però, la allontana da sé perché così era Narciso: rifiutava chiunque si innamorasse di Lui. Il bel Narciso era capace di resistere a Eros. Non era l’amante ossessivo di sé. Appariva, piuttosto, un giovane ignaro della sua bellezza e perciò puro, casto. Inconsapevole del suo bell’aspetto, egli non si lasciava abbindolare dalle lusinghe dell’amor passionale, da qualunque parte giungesse.
Comunque, tornando al racconto, accade che Ero, di fronte al rifiuto di Narciso, si dispera. Se si sta al mito, questa disperazione della ninfa non sembra originarsi solo dal rifiuto subito da Narciso, ma anche all’amara consapevolezza della condizione da cui non può fuggire: l’impossibilità di comunicare con le parole. Nemesi, dal canto suo, facendosi carico dei lamenti di Ero, punisce Narciso e lo condanna ad innamorarsi del suo riflesso nell’acqua. Una punizione che, tuttavia, non sembra meritarsi. Sta di fatto che Narciso, capendo di non poter amare la sua immagine riflessa, si lascia morire. Così si compiva la profezia del saggio indovino Tiresia. Eli aveva predetto alla madre di Narciso che costui sarebbe morto giovane qualora avesse “conosciuto sé stesso”.
Ora, per la cultura greca “conoscere sé stessi” era la forma più alta di saggezza umana. “Conosci te stesso”: questo imperativo fu posto sul timpano del tempio di Apollo a Delfi. Narciso che decide di lasciarsi morire, non lo fa, quindi, in quanto è “narcisista” secondo la consueta interpretazione odierna. Lo fa esattamente per il contrario: muore perché comprende l’impossibilità dell’amare l’immagine di sé. Narciso morente è il saggio non narcisista che conosce tragicamente sé stesso.
Come si può notare, il mito non consente di attribuire colpe o giudizi di condanna né a Ero, né a Narciso. Questi non è responsabile della sua bellezza, né del suo rifiuto. E nemmeno quella è colpevole del suo silenzio. Tutto è sottoposto al gioco e alle invidie e delle vendette assurde degli dèi che non amano chi tenta di irriderli: né chi, come Ero, tenta di distrarli, né chi cerca di resister loro come Narciso. Tant’è che il mito si conclude con una scena di compassione: le driadi cercano il corpo di Narciso per seppellirlo, ma scoprono che si è trasformato in un bellissimo fiore. La sua bellezza continuerà ad essere ammirata da altri.
Si coglie, quindi, che il tema del rispecchiamento del sé a cui fa riferimento Narciso riguarda non tanto una problematica di ordine morale, ovvero l’egoismo di chi ama sé stesso a scapito delle vite altrui, quanto piuttosto una questione di ordine antropologico: che cosa accade a chi diventa consapevole di essere innamorato della sua stessa immagine? Il focus della questione non è la bellezza di Narciso, ma la brama di questa bellezza di cui egli non può fare a meno. Una brama di cui è possibile liberarsi solo sacrificando un certo modo di esistere.
L’idea che Narciso di fronte allo specchio d’acqua vede riflessa un’immagine che brama richiama un’altra forma di rispecchiamento contenuta in un racconto fantasy contemporaneo. Si tratta dello “specchio delle brame” presentato nel primo capitolo della saga Harry Potter. Il protagonista scopre dell’esistenza di questo specchio magico per caso. Egli, guardando nello specchio, vede sé stesso insieme ai suoi genitori. Ma l’immagine è effimera: Harry, girandosi, capisce che non ci sono, che sono solo immaginari. La sua brama proietta nello specchio qualcuno che non esiste più. Come Narciso, egli vede ciò che brama. Diversamente da Narciso non è costretto e l’immagine gli risulta piacevole e consolante.
Senonché, il saggio prof. Albus Silente confida ad Harry il segreto dello specchio: la persona più felice, guardandolo, non vedrebbe altro se non sé stessa. Poi aggiunge che, per conquistare questa “conoscenza di sé”, non è saggio indugiare nelle proprie brame. In particolare, non ha senso rifugiarsi nei bei ricordi passati, smettendo di vivere. Vivere di brame… Non è vivere. È l’illusorietà del vivere. Anche in questo caso, la concupiscenza è mortifera, conduce alla morte.
Ora, lo specchio d’acqua di Narciso e lo specchio delle brame di Harry Potter rappresentano il lato oscuro del rispecchiamento di sé: quello in cui vediamo noi stessi in base a ciò che non possiamo fare a meno di desiderare tragicamente. Lo desideriamo in quanto ci appare bello, piacevole e consolante, ma non è ciò che può darci vita. Questo compulsivo attaccamento all’apparenza del bello ci incatena e ci conduce alla perdita di noi stessi.
Come suggerito da Albus Silente, per vedere noi stessi allo specchio ed esser felici dovremmo osservare la nostra bellezza senza desiderare di impossessarcene. In altre parole, dovremmo fare un’esperienza estetica della nostra immagine contemplandone il bello con libertà e gratuità verso noi stessi, senza subire la condanna di Narciso. Questo accade quando diventiamo capaci di vera autostima, cioè, di “narcisismo positivo” come lo chiamano alcuni psicanalisti. L’autostima è la modalità di rispecchiamento tipica di chi conosce la sua bellezza senza sentire il bisogno compulsivo di appropriarsene. È l’osservarsi non in forza delle brame, ma della generatività e del dono di cui ci si sa capaci.
Diventare testimoni di questa modalità di esistenza libera e capace di auto-apprezzamento non narcisistico è di capitale importanza per chi si occupa di educazione oggi. Infatti,in una società come la nostra, in cui impera Nemesi con il suo desiderio di condannare la percezione genuina della bellezza, ogni educatore ha il dovere di supportare tutti i Narcisi che incontra, aiutandoli a scoprire la loro bellezza in modo che possano contemplarla con uno sguardo grato e disinteressato.