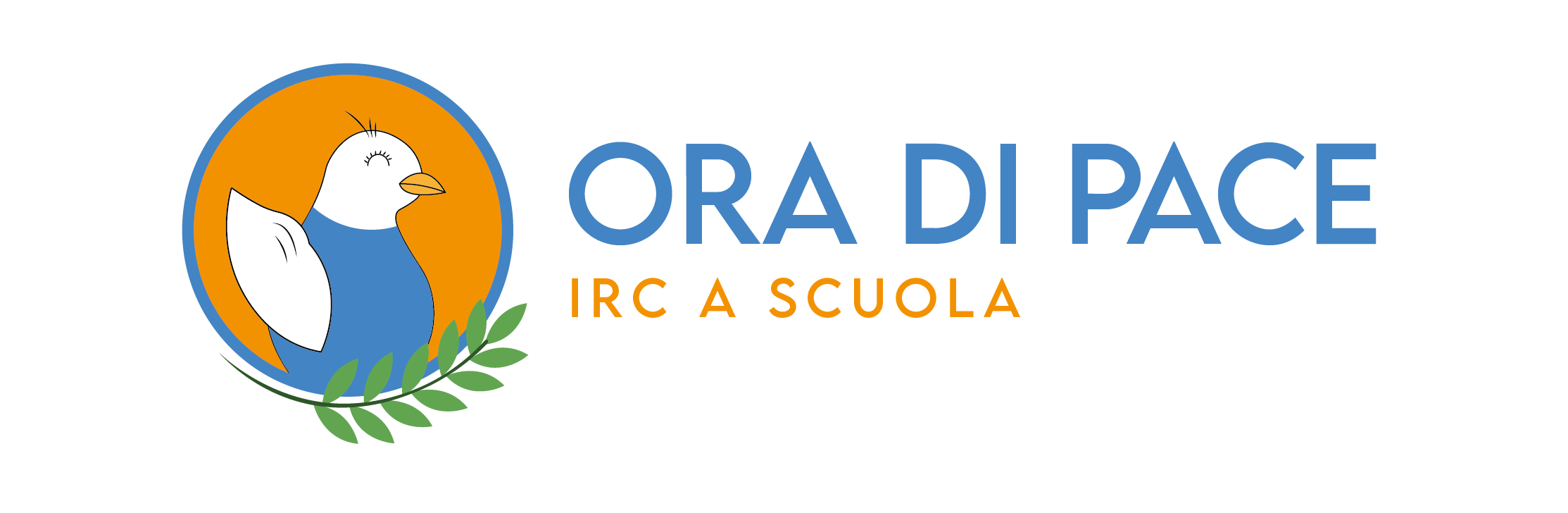L’incredibile Galileo Galilei

Di Luciano Pace
15 ottobre 1989. Circa 35 anni fa. Vittorio Messori così scriveva su un articolo di “Avvenire” queste parole:
“Stando ad un’inchiesta del Consiglio d’Europa tra gli studenti di scienze in tutti i Paesi della Comunità, quasi il 30 per cento è convinto che Galileo Galilei sia stato arso vivo sul rogo. La quasi totalità (il 97 per cento) è comunque convinta che è stato sottoposto a tortura. […] Torture? Carceri dell’Inquisizione? Rogo? Anche qui, gli studenti europei del sondaggio avrebbero qualche sorpresa. Galileo non fece un solo giorno di carcere, né fu sottoposto ad alcuna violenza fisica. Anzi, convocato a Roma per il processo, si sistemò in un alloggio di cinque stanze con vista sui Giardini Vaticani e camera personale. […] Non gli era mai stato impedito di continuare il suo lavoro e ne approfittò difatti, continuando gli studi e pubblicando un libro che è il suo capolavoro scientifico. Non gli era stato vietato di ricevere visite, così che i migliori colleghi d’Europa potessero discutere con lui. Presto gli era stato tolto anche il divieto di muoversi come voleva dalla sua villa. Gli rimase solo un obbligo: quello di recitare una volta alla settimana i sette salmi penitenziali. Questa pena, in realtà, era anch’essa scaduta dopo sette anni, ma fu continuata liberamente da un credente come lui, da un uomo che per gran parte della sua vita era stato il beniamino dei papi stessi”.
L’articolo da cui è tratta questa citazione era stato riportato per intero in un libro di testo per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Superiori del 1993, intitolato “Rendere ragione”. L’intento comunicativo degli autori era esattamente quello di snidare i pregiudizi ideologici allora ancora diffusi intorno al “caso Galilei”. Ci si potrebbe domandare: dal 1993 è cambiato qualcosa per gli studenti italiani delle scuole Secondarie di Secondo grado?
A quanto pare non proprio. Da insegnante di Religione Cattolica devo constatare un fatto: ogni anno mi capita di incontrare studenti che, volendo indicare in che cosa la Chiesa cattolica si sia resa deprecabile storicamente, citano volentieri i presunti guai che ha fatto passare al povero Galileo. C’è anche chi, con un certo coraggio, mi ha apostrofato in questo modo: “Come può lei, professore, che pare così ragionevole, prestar fede alla Chiesa dopo quello che ha fatto a Galileo Galilei?”. Insomma, se non altro, questo dimostra che i pregiudizi ideologici sono più duri ad essere abbandonati del pelo del ben noto lupo viziato, soprattutto quando è l’ateismo scientista a doverli perdere.
Ora, supponiamo che quanto scritto da Messori sia dubitabile e sospettiamo della sua buona fede nello scriverlo. Infondo – potremmo pensare – è un cattolico anche lui: è ovvio che difenderà la Chiesa dalle accuse che le sono mosse. La sua testimonianza, quindi, è viziata dalla sua appartenenza religiosa. Certo, solo chi non conosce nemmeno un poco Messori potrebbe formulare un simile dubbio su di lui. Comunque, per amor di spregiudicatezza, dubitiamo di ciò che ha scritto. Infondo, di tutto si può dubitare per indagare dove si trovi il vero.
Ci domandiamo: esiste qualche pensatore, storico, filosofo non cattolico che condivide la sua prospettiva sul “caso Galilei”? Certamente. Si tratta di Paul Feyerabend, allievo di Karl Raimund Popper. In un suo bel testo, edito in Italia da Feltrinelli, dal titolo “Contro il metodo. Per una teoria anarchica della conoscenza”, questo filosofo della scienza ha sostenuto non solo, come Messori, che non c’è alcun motivo per dubitare di ciò che la Chiesa fece a Galileo, ma, addirittura, che la condanna di Galileo fu “razionale e giusta”.
Nella versione tedesca del testo citato si trova scritto: “La Chiesa dell’epoca di Galileo si attenne alla ragione più che lo stesso Galileo, e prese in considerazione anche le conseguenze etiche e sociali della dottrina galileiana. La sua sentenza contro Galileo fu razionale e giusta, e solo per motivi di opportunità politica se ne può legittimare la revisione”.
In che modo Feyerabend giustifica questa sua presa di posizione? A suo giudizio Galileo si servì della propaganda per affermare l’eliocentrismo. In particolare, fece uso di chiare ipotesi ad hoc da lui inventate, senza tenere conto dei dati di alcune altre scienze. Per esempio, non tenne conto delle leggi di rifrazione dell’ottica applicate al telescopio, perché, semplicemente, le ignorava. Diversamente da Keplero, il quale, conoscendo simili leggi dubitava del fatto che un cannocchiale potesse offrire un’immagine esatta della realtà, Galileo ha sostenuto che il telescopio era più affidabile dell’occhio umano, perché era più potente e più utile nell’affrontare determinati problemi collegati al moto delle “stelle erranti”.
Attenzione però: questo non significa che Galileo si sbagliasse sull’eliocentrismo e che i terrapiattisti erano nella verità. Nessuno degli scienziati coevi a Galileo era terrapiattista, per la cronaca. Questa è una specie di stoltezza che, ahimè, circola sui social di oggi. La questione è più sottile: egli, pur essendo nel giusto scientifico, non poteva ancora sufficientemente dimostrare ciò di cui era convinto. Per questo motivo, Feyerabend prende come esempio di ragionevolezza il cardinale Bellarmino. Egli si mostrò “anarchico” nella conoscenza rispetto al “dogmatico” Galilei. Infatti, il porporato era disponibile ad immaginare che fosse la Terra a girare intorno al sole, come riteneva Copernico. Considerava questa un’interessante ipotesi da verificare. Di conseguenza, non era al contempo propenso a dar ragione a Galileo quando affermava con sicurezza, ma senza sufficiente suffragio di prove irrefutabili, che il sole fosse il centro dell’universo.
Notiamo bene: la tesi di Feyerabend sulla giusta condanna di Galileo non è da lui proposta per difendere acriticamente l’Inquisizione o la Chiesa. Egli ritiene che le vicende collegate a questa condanna siano, piuttosto, un buon esempio storico per mostrare il fatto che le conoscenze scientifiche procedono molte volte in modo casuale ed anarchico, spesso sfruttando i mezzi della propaganda politica e delle mode intellettuali, piuttosto che la pacatezza e il rigore dell’argomentazione filosofica tipica degli studiosi simili a Bellarmino.
E se anche questa testimonianza di Feyerabend fosse dubbia? Chi ci garantisce che egli non utilizzi le vicende storiche di Galileo solo per dar ragione al suo anarchismo epistemologico? Siamo sicuri che egli non “pieghi” i fatti storici ai suoi interessi filosofici? Sebbene chi scrive non ritiene che un simile dubbio sia corretto verso Feyerabend, con il prenderlo in esame si può citare una terza testimonianza riferita allo studio di Galileo Galilei. È la testimonianza di uno storico della scienza inglese. Mi riferisco a Frank Sherwood Taylor. Dirò poco di lui, così chi volesse meglio conoscerlo approfondirà poi per suo conto. Nel 1938 egli ha scritto un bel libro dal titolo “Galileo and the Freedom of Thought” (“Galileo e la libertà di pensiero”), non ancora tradotto in Italiano.
Questo libro è l’esito di una serie di studi storico-scientifici su Galileo e la Chiesa che egli pubblicò dopo essere stato invitato per sbaglio dalla casa editrice Rational Associated Press a tenere una conferenza sul tema. Egli scrive: “Non conoscevo bene l’argomento ma decisi di accettare ed iniziai a studiare per poter anche scrivere un libro sulla vita di Galileo. Mentre studiavo i documenti e la sua storia in dettaglio, tuttavia, mi resi conto che la leggenda comunemente accettata su Galileo era piena di deliberate distorsioni introdotte dagli scrittori anti-cattolici e razionalisti”.
Il giudizio di Taylor è concorde con quello di Feyerabend, sebbene sia dato in modo più pacato e per motivi storici e non filosofici. Nonostante la Chiesa si sbagliasse dal punto di vista scientifico (cosa che in Feyerabend, in effetti, non emerge con chiarezza), la sua cautela verso Galileo fu scientificamente e ragionevolmente fondata, visto che egli non produsse prove sufficienti per suffragare fino in fondo le sue ipotesi. Per Taylor l’Inquisizione fu “goffa” nel merito, ma esatta nel metodo. Inoltre, ancor prima che Messori venisse al mondo, egli scrisse un libro di storia della scienza in cui dichiarò che Galileo non fu mai torturato, visse con una pensione pagata dal Papa e continuando tranquillamente le sue ricerche e le sue pubblicazioni. Taylor ricorda anche che Galileo morì da buon cattolico, come sempre fu, dopo essersi confessato, aver ricevuto la Comunione e l’estrema unzione in compagnia della figlia che scelse di farsi monaca.
A seguito dello studio del “caso Galilei” Taylor modificò il suo giudizio sulla Chiesa cattolica e, in un processo lento di conversione, giunse al Battesimo nel 1941, anno in cui nacque Messori. Dopo la sua conversione continuò a studiare storia della scienza e a coltivare i suoi interessi, in particolare dedicandosi al rapporto fra alchimia antica e chimica moderna. Fu talmente apprezzato per il suo lavoro che divenne anche direttore del Museo delle Scienze di Londra.
Insomma: c’erano un giornalista italiano, un filosofo tedesco e uno scienziato inglese che hanno studiato il contrasto fra la Chiesa e Galileo Galilei… Sembra l’inizio di una barzelletta. Non è così. È il termine di una vicenda drammatica che narra la persistenza di un infondato pregiudizio ancora largamente creduto e diffuso: l’idea secondo cui Galileo Galilei sia stato il primo presunto ateo razionalista, oltremodo vessato dai cattivi e violenti inquisitori quando, invece, fu un geniale scienziato credente, legittimamente contestato dai suoi altrettanto illustri colleghi. Questi, evidentemente, erano in errore. Oggi lo sappiamo. Ma sappiamo anche che Galileo non aveva a suo tempo tutte le evidenze per suffragare l’eliocentrismo, visto che la prova sperimentale giungerà solo nel 1851 con l’esperimento del Pendolo di Foucault. In seguito, Albert Einstein chiarì che i pianeti non orbitano attorno al Sole in senso stretto, ma seguono traiettorie rettilinee all’interno di uno spazio-tempo curvato dal campo gravitazionale solare, secondo la relatività generale.
Per tutte queste ragioni, ciò che il “caso Galileo” insegna non è tanto quanto la Chiesa sia stata politicamente ingiusta verso di lui, ma quanto la scienza sperimentale, di cui egli fu illustre iniziatore, proceda per ipotesi la cui correttezza non è così facile da dimostrare. L’esercizio di critica e di dubbio verso nuove prospettive teoriche si addice, quindi, a chi coltiva le scienze, quand’anche i dubbi e le critiche si rivelassero alla fine infondati. Messori, Feyerabend, Taylor hanno ben compreso questa lezione. Lo stesso raziocinio, al contrario, non sembra essere esercitato da chi ancora oggi ancora crede su Galileo quanto Messori scrisse con chiarezza nel 1989 nel suo articolo di “Avvenire”.